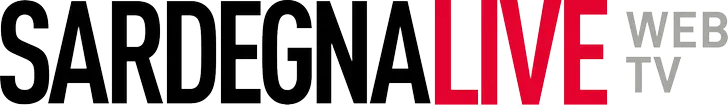PHOTO
“Dove abiti? A Buoncammino, non lì, però”. Diverso era dire “abito in Castello”, uno dei quattro quartieri più antichi, nobili e ricchi di storia della città di Cagliari. Quante volte tra studenti universitari ci si scambiava gli indirizzi e quello di Buoncammino faceva sempre sorridere ed era tutte le volte, con simpatica ironia, un motivo di enfatica e divertita precisazione.
Già, Buoncammino a Cagliari era solo carcere, tutto il resto non faceva cartello, almeno nell’immaginario collettivo. Eppure c’erano, e in parte ci sono tuttora, altre istituzioni di rilievo: il Tribunale militare, il Corpo di polizia di Stato, il vicino museo archeologico e altro ancora. E poi la parte residenziale del colle, con delle vedute panoramiche incantevoli su tutta la città. No, il carcere era un’altra cosa.

Era l’inferno per i peccatori di una società che non di rado li spediva lì dentro anche se innocenti. O, comunque, li mandava a morire, nello spirito, ma a volte, tragicamente, anche nel fisico. Infatti, con alterne vicende dai primi del ‘900 in poi, quello di Buoncammino era più di un carcere: difficile immaginarne di peggio. Uno dei mali di sempre, il sovraffollamento. E poi un’infrastruttura rivelatasi sempre meno adatta, nonostante la buona volontà di tutti i direttori che si sono succeduti, a recepire i mutamenti legislativi voluti, ad esempio, da una legge del ’75 che prevedeva attività sportive, culturali e ricreative rivelatesi però impraticabili per mancanza di spazi.
Lodevole e significativa, nello slancio di un messaggio non fine a se stesso, fu l’iniziativa, negli anni ‘80, di collocare nel piazzale del carcere una lastra di marmo riportante l’art. 27 della Costituzione: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.

Complici, certo, difficoltà anche obiettive, di fatto, però, la vita carceraria di Buoncammino è stata sempre contrassegnata da una costante tutta italiana: persistente disumanità – e non per colpa del personale di servizio, costretto anch’esso a una vita difficile a causa di ricorrenti problemi di organico – nel sentiero di un processo di rieducazione e di recupero troppo lento nella sua realizzazione.
Quanti reportage, quante inchieste, ispezioni ministeriali o visite di politici. Nell’antico carcere, però, nulla cambiava: si continuava a morire, a non vivere. Celle affollate, detenuti stipati all’inverosimile, servizi igienici indefinibili. Ecco cosa si veniva a sapere del carcere attraverso le notizie di chi poteva descriverne le sue precarie condizioni. Poi la chiusura, e oggi l’oblio. Ma questa è una storia recente, di un altrimenti anonimo mese di novembre 2014, anno in cui i detenuti lasciano le antiche sbarre troppo severe e inclementi per altre, quelle del nuovo istituto di detenzione di Uta, chissà, forse meno infide. Buoncammino, ciò che si intendeva con questo nome, il carcere, non c’è più.
Non si vedrà più nell’omonimo viale, davanti all’ingresso dell’ “inferno”, il capannello parenti dei detenuti in attesa, sempre dignitosa, di entrare nel parlatorio per portare un po’ di umanità in una prigione senza volto. Così come non si sentirà mai più il vociare o le urla senza risposta dei detenuti che un tempo, quando c’erano ancora le bocche di lupo, arrivava fino all’orecchio degli innamorati che la sera, tra i giardini di viale S. Vincenzo e viale Buoncammino, davano anch’essi un senso a una città moderna, rassicurante, ma forse non sempre attenta e sufficientemente sensib