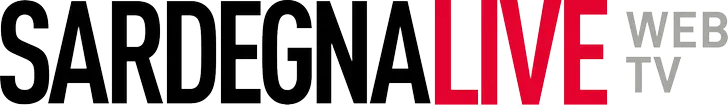PHOTO
Riccardo Salvetti nasce nel 1986, giovanissimo affronta tutte le sfide del suo percorso artistico e lavorativo riuscendo a muoversi con disinvoltura in un mondo, non sempre facile, come quello del cinema. Continua a ricevere consensi in giro per il mondo emozionando migliaia di persone e portando il pubblico a guardare anche il cinema italiano, senza mai deludere. Oltre al cinema, ama viaggiare, leggere manga e andare in mountain bike. Arriva al successo con “ Rwanda”, un film che porta sullo schermo una pagina di storia: il genocidio dei Tutsi nel 1994. In 104 giorni sono state uccise oltre 800.000 persone della minoranza etnico-sociale dei Tutsi trucidati a colpi di machete dagli estremisti Hutu. Un genocidio avvenuto nell’indifferenza più totale.
“Racconto storie sperimentando la contaminazione di generi, in una narrazione che spesso esplora toni onirici e surreali, con sguardo sensibile alle tematiche sociali”
Ciao Riccardo e benvenuto su Sardegna Live
Sei uno tra i più promettenti registi italiani, in che modo sei arrivato al cinema e alla regia?
“Il mio percorso cinematografico è ancora molto giovane e quindi potremmo dire che è una navigazione in corso, proseguirà libera verso l’orizzonte senza avere come meta un porto preciso. I primi esperimenti “cinematografici” li ho realizzati da adolescente, quando con la telecamera di famiglia, mi divertivo ad immortalare reportage delle vacanze o passavo le estati a realizzare piccole storie horror con gli amici. Poi, dopo la maturità, quando ho capito che volevo percorrere questa strada, ho cominciato a lavorare in una televisione locale a Forlì, la mia città, e in seguito ho proseguito gli studi in ambito cinematografico alla scuola civica di “cinema televisione e nuovi media – Luchino Visconti” di Milano. La formazione scolastica è servita da spartiacque, tra i primi esperimenti lucidi con gli amici e un percorso professionale consapevole del linguaggio della macchina da presa”.
L’opera che inizialmente ha attirato l’attenzione su di te è stata “Rwanda”. Com’è nata l’idea di trattare un tema così delicato? E che atmosfera si respirava durante le riprese?
“Rwanda è un film che ha significato tanto per me, come in fondo ogni opera realizzata, ma questo film è stato forse il più impegnativo; un po’ per la delicatezza del tema, un po’ perché è un film ambientato in Africa, ma girato tutto in Italia e poi era la prima opera di lungometraggio di fiction che realizzavo.
L’idea nasce dal progetto di trasporre, in chiave cinematografica, lo spettacolo teatrale omonimo di Marco Cortesi e Mara Moschini. E la chiave narrativa dell’opera stessa sta proprio nella sua origine, dovevamo parlare di una tragica parentesi della storia umana dove paura, pregiudizio, differenze hanno mobilitato tutto quello che è accaduto in Rwanda nel 1994, sotto l’indifferenza dell’occidente e dell’uomo bianco.
Da qui l’idea di partire proprio dallo spettacolo teatrale e attraverso la magia del teatro, trascinare i due protagonisti bianchi a vivere in prima persona la storia vera raccontata da due sopravvissuti al genocidio. Vestire i panni dell’altro è l’unico modo per capirne le origini e dissipare il pregiudizio.
Un film che parla di una vicenda passata, ma che al contempo è sempre attuale riguardo a tematiche di accettazione, migrazione, accoglienza e inclusione. Spesso bisognerebbe conoscere la storia dell’altro prima di parlare. E di storie ne abbiamo sentite tante durante le riprese, abbiamo visto persone che quel genocidio, che noi portavamo in scena, lo avevano vissuto davvero sulla propria pelle, perdendo famigliari o bambini portati in salvo in altri paesi per non rimanere vittime dei massacri. Senza mai conoscere le sorti della propria famiglia. E’ stato un film intenso sotto ogni punto di vista”.
Ti va di raccontarci un episodio, che non dimenticherai mai, avvenuto durante le riprese dei tuoi film?
“Durante le riprese sono una persona molto esigente, a volte troppo. Sono abituato a voler ottenere la massima resa e per questo spingo sempre troupe e attori al loro limite, e su un film come Rwanda il limite comportava interpretazioni emotive forti per il cast.
Una sera ho preteso davvero tanto da una attrice, portandola ad uno stato emotivo che poi, anche a fine riprese non riusciva a digerire. A volte per alcuni attori non è difficile trovare l’emozione giusta per entrare in scena, ma può essere complicato poi liberarsene a fine set. Così sono rimasto con lei dopo l’ultimo ciak a cercare di calmarla e a ringraziarla per aver dato il massimo durante le riprese. Ci siamo abbracciati e nella mia memoria quell’abbraccio è uno dei momenti più indelebili nella produzione di Rwanda. Da quell’abbraccio, anche dopo il film qualcosa di forte ha continuato a legarci, fino a diventare marito e moglie”.
Reclusione e isolamento sociale sono i temi trattati in Closed box, ci vuoi parlare di quest’opera?
“Da quando è iniziata l’emergenza Covid è un film tristemente tornato attuale. Closed Box è tornato a partecipare ad alcuni festival sensibili al tema della reclusione e dell’isolamento. Oggi siamo un po' costretti a queste limitazioni sociali, mentre al tempo in cui diressi questo cortometraggio, ricordo lo stupore nel leggere di questa notizia di cronaca. In un’epoca dove i social diventavano sempre più diffusi ed utilizzati, scoprire che una persona aveva scelto di percorrere la direzione opposta, isolandosi sempre di più, fino a chiudersi a vivere dentro una scatola, era un fatto che non poteva passare inosservato. E’ stato davvero importante trasformare in immagini questo grido di aiuto rimasto inascoltato. E’ forse l’opera più astratta, onirica ed evocativa di tutti i miei film, ma continuo ad amarla per il suo essere completamente indipendente e pura nel percorso narrativo”.
Con il film “Il muro” hai usato una forma di narrazione sperimentale molto particolare, è stata una mossa vincente?
“Con Rwanda era già iniziata una fase dove la contaminazione di generi mi dava forti ispirazioni. Con “Il Muro” ho, semplicemente, esasperato la sperimentazione creando un racconto documentaristico per la televisione che fondesse fiction e documentario, cinema e teatro. Questo al fine di semplificare alcuni percorsi narrativi ottimizzando il budget che avevamo a disposizione e lavorando sulla ricerca di situazioni oniriche, che alla lontana, ricordavano qualche scena di Closed Box, con uno sviluppo forse più maturo. Il film è stato presentato in Rai per i 30 anni della caduta del muro di Berlino e purtroppo non è stato distribuito in sala perché i cinema sono stati chiusi. Non ho avuto modo di verificare se, come dici tu, il linguaggio sarebbe stato “vincente”. Non so che effetto avrebbe fatto vedere un film del genere in un cinema, è stato molto apprezzato nelle messe in onda, ma penso che il suo taglio ideale fosse comunque quello televisivo per cui nasceva”.
Per finire la classica domanda: hai un progetto in cantiere di cui vuoi parlarci?
Di recente sto lavorando allo sviluppo di un soggetto che ho scritto insieme a Renato Billi (sceneggiatore di Forlì) un film che ha vinto il bando del ministero della cultura per la scrittura di sceneggiatura. La storia è ispirata a un fatto personale accaduto nella mia famiglia, una vicenda che parla di affetti, salute e pranzi di famiglia, che si svolge tutto in una unica location. Ora siamo alla ricerca di una produzione e spero presto di poter tornare sul set per realizzare questa nuova opera”.