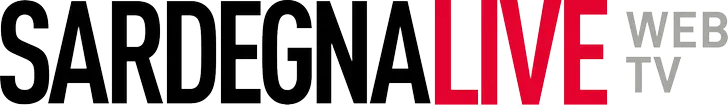PHOTO
Il silenzio solitario che accompagna questo caldo primaverile è in contrasto con i luoghi in cui normalmente lo si può incontrare: sui palchi inondati di note, colori e costumi, nei frenetici studi televisivi tra le corse della diretta e voci che cantano, nei tanti paesi dell’isola che trasmettono attraverso le bancarelle che dichiarano la festa, buona parte delle sue canzoni, e le altre, quelle che contribuisce a far diventare successi, grazie al suo mestiere di presentatore.
Giuliano Marongiu abita in un bell’appartamento nelle vicinanze di Cagliari, pieno di libri e dischi che hanno come denominatore comune la Sardegna, maschere tradizionali del Carnevale Barbaricino, una litografia di Maria Lai e un colore che domina su tutto: il blu.
Ad un buon esperto di psicologia non sfuggirebbe questa predominanza di blu che ti circonda…
Esistono le teorie dei colori. Il blu rappresenterebbe il colore dell’anima, l’acqua calma e profonda, la lealtà, la profondità dei sentimenti, l’acutezza meditativa.
Ti riconosci in queste linee di significato?
Sulla lealtà e la profondità dei sentimenti senza dubbio. Non ho mai tradito le amicizie, e quelle che ho considerato tali, poche ma eccelse, mi accompagnano dal momento in cui sono sbocciate. Mi sono sentito tradito, in alcuni casi: ho chiuso nel cuore quel che di bello c’era stato e con uno spessore di sofferenza in più sono andato avanti.
Credi anche tu che l’artista sia in qualche modo condannato alla solitudine?
Penso che in chi si espone, con la propria anima e i propri sentimenti, ci sia una maggiore predisposizione al giudizio, alla ricerca del consenso per quello che fai e soprattutto per quello che sei, altrimenti basterebbe cimentarsi davanti allo specchio di casa. Questa ricerca riflette a priori un disagio con se stessi e la voglia di comunicare è cercare un qualcosa negli altri: un ascolto, un’attenzione. Non credo che l’artista in quanto tale sia condannato alla solitudine: credo che certe solitudini trovino nutrimento nella radice creativa e viceversa.
Ti ho conosciuto a Tonara nel 1991. Presentavi il Festival del Cabaret di Tonara. Io ero tra i concorrenti in gara, tu al tuo debutto ufficiale. Formidabili quegli anni?
Si, ero proprio un ragazzino, e attraversai quell’esperienza con Ottavio Nieddu che era “il” presentatore. Tu però mi sembravi già grande… (scherzo!). Il Festival del Cabaret fu una bellissima intuizione. Nei primi anni Novanta vennero fuori da quel Festival grossi nomi come La Pola, Giuseppe Masia, Giuliano Murgia, Pierfrancesco Loche. In due edizioni ho lavorato gomito a gomito con Giorgio Panariello. Preparavamo insieme le scalette, ci divertivamo tanto. Qualche anno fa, quando è stato in Sardegna per i suoi grandi eventi, ha dichiarato di seguire le nostre trasmissioni regionali e attraverso un amico cameramen di Videolina mi ha mandato affettuosi saluti. Mi ha fatto piacere.
Hai altri ricordi di quel periodo?
Si. Ho fatto di tutto. Intanto giravo la Sardegna con una Fiat Cinquecento scassata che non mi ha mai lasciato a piedi. Alternavo le mie tappe in qualità di ballerino del Gruppo Folk di Ovodda (i semi della tradizione…), a spettacoli che improvvisavo: ad esempio i giochi senza quartiere in tanti paesi. Ricordo a Nughedu Santa Vittoria, insieme all’inseparabile Massimo Pitzalis, di aver fatto rovesciare il paese in quanto le quattro squadre (una per ogni zona dell’abitato), dovevano nell’arco di mezz’ora portare sul palco un asino, una gallina, un maiale, un coniglio oltre al più grande numero di mutande, reggiseni, scarpe, calze ecc. Puoi immaginare la montagna di indumenti riversati e “la vecchia fattoria” che si animava sul palco allo scadere del tempo. Il premio in palio ammontava a centomila lire, ma il divertimento di un’intera comunità non ha più avuto un prezzo così