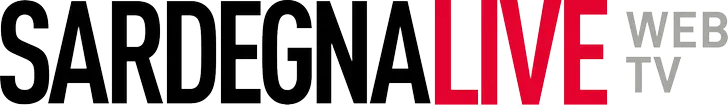PHOTO
Il 15 febbraio 1910, sulle pagine del Corriere della Sera appare un breve scritto pubblicato a nome di Gabriele d’Annunzio, titolato “Un itinerario bacchico”. Qua, “il Vate” ripropone le parole che egli stesso scrisse, l’anno precedente, in una lettera spedita all’amico Hans Barth, giornalista e scrittore tedesco, grande appassionato di vini italiani e autore di una guida dal titolo “Osteria. Guida spirituale delle osterie italiane da Verona a Capri”, (1909). Nell’occasione, Barth chiese a D’Annunzio di contribuire alla sua opera con una prefazione, e di fornirgli informazioni sulle osterie pisane. Lo scrittore pescarese, autodefinitosi “acquatico” (astemio), non seppe soddisfare appieno la richiesta, ma fornì a suo modo una testimonianza del tutto originale di una particolare e felice esperienza vissuta in passato: il suo viaggio in Sardegna.
Un itinerario bacchico
Come detto poc’anzi, il pezzo pubblicato da D’Annunzio sul Corriere traeva ispirazione da un suo precedente viaggio giovanile nell’Isola, compiuto nel 1882 in compagnia degli scrittori e amici Edoardo Scarfoglio e Cesare Pascarella, collaboratori della rivista romana Capitan Fracassa. Aveva ancora 19 anni, il suo percorso artistico era in fase di fioritura ma era già noto al pubblico per la raccolta “Primo Vere”. Lo sbarco a Olbia (allora era Terranova) e le tappe ad Alghero, Nuoro, Cagliari, Villacidro e Oliena. Proprio quest’ultima è teatro delle vicende narrate D’Annunzio nel suo aneddoto: ospitato da una famiglia locale, nonostante la sua professata astemìa, il romanziere rimase estasiato, senza assaggiarlo, dal profumo inebriante del Nepente, che invece assaporarono (eccome se lo fecero!) i suoi compagni di viaggio. Tanto bastò a ispirare ricordi, pensieri e parole.
La promessa
Così, quegli avvolgenti bicchieri di cannonau divennero, anni addietro, motivo di appassionato e nostalgico racconto. “Ma se pur vorrete sostare alla foce dell’Arno – esordisce la lettera – […], io vi prometto di sacrificare alla vostra sete un boccione d’olente vino d’Oliena serbato da moltissimi anni in memoria della più vasta sbornia di cui sia stato io testimone e complice. Non conoscete il Nepente di Oliena neppure per fama? Ahi lasso! Io son certo che, se ne beveste un sorso, non vorreste mai più partirvi dall’ombra delle candide rupi, e scegliereste per vostro eremo una di quelle cellette scarpellate nel macigno che i sardi chiamano Domos de Janas, per quivi spugnosamente vivere in estasi fra caratello e quarteruolo. Io non lo conosco se non all’odore; e l’odore, indicibile, bastò a inebriarmi”.
Arrivo e accoglienza ad Oliena
Ricorda ancora: “Eravamo clerici vagantes per un selvatico maggio di Sardegna, io, Edoardo Scarfoglio e Cesare Pascarella, or è gran tempo, quando giungemmo nella patria del rimatore Raimondo Congiu piena di pastori e di tessitrici, ricca d’olio e di miele, ospitale tra i Sepolcri dei Giganti e le Case delle Fate. Subito i maggiorenti del popolo ci vennero incontro su la via come a ospiti ignoti; e ciascuno volle farci gli onori della sua soglia, a gara. Ah, mio sitibondo Hans Barh, come le vostre nari sagaci avrebbero palpitato allorché il rosso Nepente sgorgò dal vetro con quel gorgoglio che suol trarvi dal gorgozzule quei ‘certi amorevoli scrocchi’ […]. Certo – riflette –, chi beve quel vino non ha bisogno d’inghirlandarsi”.
Il dono, la sbornia e l’epilogo
Durante l’ultima tappa, l’autore viene riconosciuto come il figlio di un benefattore del padrone di casa: “Ora accadde che nell'ultima casa, affacciata sopra un uliveto più bello e più santo di quelli che ombrano la vita di Delfo, domandando l'ospite a ciascuno di noi notizie del nostro paese natale, io fossi da lui riconosciuto come il figlio del signore che nel lontano Abruzzo per singolari vicende l'aveva accolto secondo l'antico nostro costume liberale. Commosso dal ricordo sino alle lacrime, se bene avesse un occhio solo, egli si profuse in carezze verso me e i compagni con tanto calore alla mi sentii perduto. Ma il Pasca votò anche una volta tre e tre coppe (Pascarella continuava a bere le rituali “tre coppe” per ciascuna dimora in cui erano ospiti, ndr). E io m'ebbi in dono una pelle di cinghiale, un lungo fucile damaschinato d'argento e un caratello”.
D’Annunzio racconta con ironia e simbolismo la sbornia di Pascarella, che era talmente ubriaco da volersi togliere i pantaloni impolverati per indossare la toga come un antico cittadino romano (un “Quirite”): “Quando uscimmo per raggiungere la nostra vettura, il generosissimo sostituto (Pascarella, ndr) era già trasformato in prisco Quinte e voleva lasciar su la via le vili brache polverose per vestire a guisa di toga illustre iI cuoio irsuto. Gli persuademmo ch'egli fosse già regate. E allora meravigliosamente sragionando, come s'egli avesse consuetudine della lunga veste, faceva l'atto di accogliere al petto le pieghe della destra parte e dl comporre sul braccio sinistro quella specie di tracolla che dicevasi in Roma il seno della toga. E in quel seno immaginario, pieno d'una inesausta eloquenza, fu di certo concepita primamente la Storia romana. Esso poi e il Quirite (Pascarella e il suo alter ego, ndr) si riempirono d’un letargo che durò due giorni. Ma in tutto (udite, luterano ligio alle regole papali!) la sbornia d'Oliena fu quadriurna”.
Ode ed esortazione
D’Annunzio conclude esortando l’amico Hans Barth a visitare Oliena e la Sardegna, in un viaggio onirico fra “estasi e silenzio”, raccontando l’incanto e descrivendo il fascino senza tempo delle Domus de Janas e delle Tombe dei Giganti: “Andate dunque da Monterosso di Mare a Oliena d'Oltremare, valicando il Tirreno sino al Golfo dl Orosei, magari in velivolo, o stirpe di Otto Lilienthal. Son certo che là è la meta sublime delle vostre peregrinazioni eloquenti; là è l'estasi e il silenzio, in una Casa di Fata e in un Sepolcro di Gigante. E il ricordo di tutte le taverne laudate, dalla Verona della Luna, alla Capri di Herman Moll, sarà vanito. E, preludendo e interludendo su le canne della launedda paesana, voi canterete i versetti del salmo supremo, a imitazione di Minatchehr”.