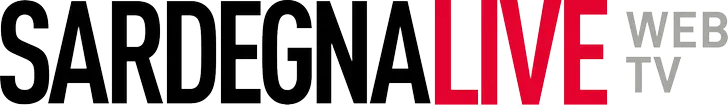PHOTO
Ha deciso di mettere nero su bianco ciò che ha passato, i momenti più brutti legati alla sua patologia, ha voluto scrivere un libro che uscirà a breve per dare forza e coraggio a chi probabilmente è nelle sue stesse condizioni (sono 23 le persone in tutto il mondo, compresa Daniela, che soffrono di questa rara patologia) o di chi sta ancor peggio.
“Ho deciso di raccontarvi quelli che forse, probabilmente saranno gli ultimi giorni della mia vita; vorrei che restasse un segno di me su questa terra ma soprattutto vorrei che sappiate quanto il mio unico, vero e grande amore mi è stato vicino, di tutte le volte che mi ha asciugato le lacrime e di quante ha fatto in modo che non ne versassi altre, di quando mi ha reso la persona più ricca del mondo solo con la sua presenza… vorrei che anche voi possiate innamorarvi di lui… DEL MIO CANE. “
Daniela Floris, 39 anni, di Iglesias (abita da parecchi anni a Portoscuso), di mestiere fa la guardia giurata: ha deciso di raccontare al nostro giornale la sua storia, fatta di ricoveri, letti di ospedale e di tanta sofferenza, affrontata grazie alla vicinanza dei suoi genitori Bruno e Cristina, della sorellina Silvia, di tutti i suoi cani Scyuby, Shaira, Shelly, Shonny e Pan, ai due medici che le hanno salvato la vita, il professor Alberto Bertolini (Ospedale Gaslini di Genova) e il dottor Gaetano Gargiulo, (Ospedale S. Orsola di Bologna).
“Se pensate che i cani siano “solo cani”, allora non continuate neanche a leggere, rimettete questo libro nello scaffale e lasciate che un’altra persona, con un cuore migliore del vostro, possa prenderlo, leggerlo e magari regalare un po di amore ad un essere bisognoso, abbandonato n qualche canile fatiscente o lasciato agonizzante in strada”.
Sardegna Live pubblica la prefazione del volume, mentre il “cuore pulsante” della storia sarà contenuta all’interno del libro che uscirà prossimamente e che potrete leggere integralmente. Buona lettura e forza Daniela. (A.C.)
“Circa 40 anni fa, in un sabato di piena estate, per la gioia dei miei genitori, sono nata io, una pargoletta di appena 2.750 kg alla quale la vita ha presentato immediatamente il conto, un conto che tutt’ora devo pagare… La contentezza dei miei genitori infatti finì troppo presto, da subito mia madre aveva notato che non ero come gli altri bambini: avevo sempre il pancino gonfio, rigurgitavo e piangevo di continuo, certo… tutti i bambini piangono, ma a detta sua, il mio era un pianto disperato, una ricerca continua di aiuto.
Mia madre aveva appena 26 anni, era giovane e bella ma non stupida come avevano pensato i medici quando per l’ennesima volta, nel giro di 3 mesi, mi aveva accompagnata in ospedale.
“Signora, lo vuole capire che sua figlia non ha nulla? Lei è pazza, è la classica donna che soffre di depressione post partum, se non voleva questa bambina bastava non metterla al mondo!”. Questo è ciò che le fu detto da un medico, innervosito dalla nostra persistente presenza in quello squallido corridoio del pronto soccorso.
Mio padre non ha mai avuto dubbi sulla salute mentale di mia madre, le ha sempre creduto e sempre l’ha sostenuta ma ovviamente non ha vissuto 24 ore su 24 a stretto contatto con me perché doveva lavorare, quindi, più che altro, era lei che doveva subire il mio continuo pianto e pulirmi da tutto quel rigurgito ed era sempre lei costretta a pellegrinare da un ospedale all’altro in cerca di una risposta… o almeno fino a quel giorno era stata lei, perché quando gli raccontò della gelida ed arrogante opinione ricevuta da quel medico le cose cambiarono. Fecero ricerche su ricerche per capire quale fosse il miglior ospedale italiano, a quei tempi non esisteva neanche internet, non so come abbiano fatto a decidere su dove e non dove portarmi.
Insieme presero la situazione in mano e quei quattro soldi che avevano da parte, fecero una valigia e dalla Sardegna giunsero fino all’Ospedale Gaslini di Genova.
Arrivai lì che avevo appena 3 mesi e fui dimessa 6 mesi dopo, durante i quali non avevo più avuto contatti con i mei genitori, mia madre non poteva nemmeno allattarmi perché dovevo stare in una camera sterile dove venivo alimentata con latte artificiale, i miei genitori potevano vedermi solo attraverso un vetro, dev’essere stato straziante per loro.
La mia diagnosi fu presto fatta, o meglio passarono bel 6 mesi di degenza prima di avere quello che io chiamo il verdetto: da questo momento in poi mio padre e mia madre dovevano rassegnarsi ed accettare che la propria figlia sarebbe stata costretta a convivere con la sua malattia: la Sindrome di Bland White Garland, una rara cardiopatia che colpisce un bambino ogni 300.000 nati vivi.
Fu un continuo susseguirsi di ricoveri e di regole da dovermi far rispettare, ci sono tante cose che non ho mai conosciuto a causa dei miei gravi problemi di salute, ad esempio non so cosa significhi correre perché non ce l’ho mai fatta, e quando da piccola gli altri giocavano a nascondino io dovevo trovarmi un’alternativa per non invidiarli, ma nonostante questo (ed altro) non mi sono mai sentita inferiore a nessuno, non ho mai pensato di avere qualcosa in meno ma qualcosa in più: mentre gli altri conoscevano solo il divertimento io conoscevo anche il dolore, mentre gli altri si lagnavano e spesso piangevano senza motivo, io che di motivi ne avrei avuti tanti continuavo a sorridere; mentre loro programmavano le vacanze estive, io mi illudevo di fare altrettanto ma in realtà le mie vacanze le passavo sempre nella stessa camera sterile lì al Gaslini. Così quando si tornava a scuola e la maestra ci faceva fare il tema descrittivo delle nostre vacanze iniziava il mio viaggio, fatto di fantasia, nel quale la mia camera sterile si trasformava in una lussuosa suite con vista mare e avevo un bellissimo letto a baldacchino come quello delle principesse mentre in realtà non era altro che un letto con la tenda dell’ossigeno per consentirmi di respirare meglio, le infermiere erano le mie cameriere personali ed i medici gli animatori del mio villaggio turistico immaginario; tutto era perfetto anche la farfallina verde dell’ago col quale mi toglievano il sangue ogni mattina era diventata all’improvviso una meravigliosa Papilio Paris, le flebo si trasformavano in un liquido pregiato che solo pochi bambini potevano avere a disposizione ed io ero tra quelli; la notte poi mi teneva compagnia il suono dell’elettrocardiogramma che avevo costantemente collegato al mio cuore, era il mio piano bar preferito con un ritmo assordante che ancora oggi in realtà mi terrorizza. Ricordo anche gli odori che c’erano all’interno del mio reparto: il disinfettante, il materiale con cui sono fatte le mascherine e tante altre cose ma che non sono mai riuscita a descrivere, o forse non ci ho mai provato, però le ricordo ancora. In tutti questi anni solo una volta mio padre si è potuto permettere di portare tutta la famiglia a fare una vacanza vera, i soldi ci servivano sempre per le mie trasferte in ospedale e quelle dovevano essere le mie vacanze.
Ogni volta che andavo al Gaslini, tutti i miei giochini dovevano stare fuori dalla mia camera sterile… niente pupazzi, niente bambolotti, niente di niente… ricordo che un giorno sono riuscita a tenere con me una statuetta di plastica con la quale a casa dormivo, era un oggetto talmente piccolo che ci stava in una mano e lo avevo nascosto dentro la tasca della giacca, ero così brava che ormai le infermiere non mi “perquisivano” più per vedere se avessi oggetti con me. Arrivata in ospedale, mia madre mi mise il pigiama e nell’attimo in cui lei si girò per riordinare la mia roba, magicamente riuscii a spostare quella statuetta dalla tasca della giacca a quella del pigiama; non mi sembrava vero e per un attimo mi ero illusa che quel pezzo di plastica potesse restare con me durante il ricovero. Poco dopo entrò un’infermiera, sicuramente aveva notato qualcosa di strano dentro la tasca, così mi disse con infinita dolcezza che doveva lavare il mio pigiama e mi fece mettere quello di ricambio, ignara che quello sarebbe stato un inganno e dimenticandomi della mia marachella, da quel momento in poi non rividi mai più la mia statuetta.
In tutti quegli anni passati al Gaslini, non ho mai potuto stringere amicizie con gli altri bambini perché i miei ricoveri erano sempre fatti in camere sterili quindi dovevo stare da sola, gli unici amici che avevo erano i piccioni che si poggiavano sulla finestra della mia stanza, i miei preferiti erano quelli bianchi.
Alle volte, dalla finestrella della mia stanza, vedevo i nuovi ricoveri delle camere affianco, la maggior parte di loro entrava dopo di me ed usciva prima di me, io invece ero sempre lì, le mie dimissioni sembravano non arrivare mai; solo una volta è successo che una bambina si è trattenuta quanto me, si chiamava Maria, era una neonata siciliana nata sordo-cieca, ricordo che non piangeva mai, non ho mai sentito la sua vocina… io alle volte piangevo, lei no, così chiesi a mia madre perché quella bambina non piangesse mai, mi disse che Maria non sentiva nulla, non vedeva nulla e non provava alcun tipo di dolore, non so se quest’ultima cosa fosse vera però non mi spiegavo minimamente perché non piangesse nemmeno quando la mattina le mettevano la farfallina verde per toglierle il sangue. Il giorno delle mie dimissioni, furono anche il giorno delle sue; uscì dalla mia camera presa per mano con mia madre e raggiungemmo mio padre che nel mentre aspettava il suo turno per ritirare in segreteria gli ennesimi referti, prima di lui c’era un signore che piangeva ed una signora che urlava il nome di Maria, mia madre mi portò via da quella sala d’attesa ma soprattutto da quella scena straziante, anche se non me l’ha mai detto, avevo capito da subito che Maria non ce l’aveva fatta e ad attenderla non c’era un taxi come per me, ma un carro funebre. Ancora oggi, sentire qualcuno urlare mi fa uscire di testa, nella mia mente viaggiano veloci le immagini di quel giorno, è come se il tempo si fosse fermato lì.
Sapete, sono cresciuta nella convinzione di essere una gran bugiarda, quelle poche volte che da piccola mi sono lamentata perché stavo male, mi sono sempre sentita ripetere da mio padre che non era vero, che io ero sana e non avevo nulla, allora mi sono abituata all’idea che il “non poter fare niente” fosse una situazione normale e che erano gli altri bambini ad essere diversi; così ho preso il mio dolore e l’ho trasformato in coraggio e quando mi si chiedeva come stavo, rispondevo che andava tutto bene, eppure non era così. Imparai a tenermi il dolore dentro, tanto lamentarsi non serviva a nulla, non era vero che ero malata quindi perché continuare a mentire? Questa mia convinzione a breve cominciò a distorcersi, crescevo ed i medici cominciavano a spiegarmi le cose: alle scuole elementari e medie mi spiegarono che non potevo fare educazione fisica come gli altri perché il mio cuore era debole e ogni volta che andavo per le visite di controllo aggiungevano sempre un puzzle alla mia situazione clinica fino a quando mi fu spiegata tutta la verità.
Sono tante le cose che potrei raccontare, i miei problemi di salute non sono mai finiti, ho sempre sopravvissuto ma mai vissuto, o forse ho vissuto e anche meglio di voi, chi lo sa! Tutto dipende dal proprio punto di vista ma una cosa è certa: se dovessi rinascere, vorrei nascere esattamente così come sono in questa vita! Penso che se il dolore ti affligge, tu devi essere più forte del dolore, devi trovare il modo per schiacciarlo o almeno devi combatterlo, nessuno fa miracoli se non i medici.
Credetemi, anche io stavo per cedere, non avevo più voglia di continuare a farmi rivoltare come un calzino dai medici, la mia situazione di salute era quella, dovevo farmene una ragione ma alla fine un motivo per andare avanti l’ho trovato, quel motivo si chiama SHONNY, quel motivo è il mio cane”.