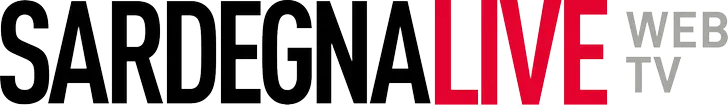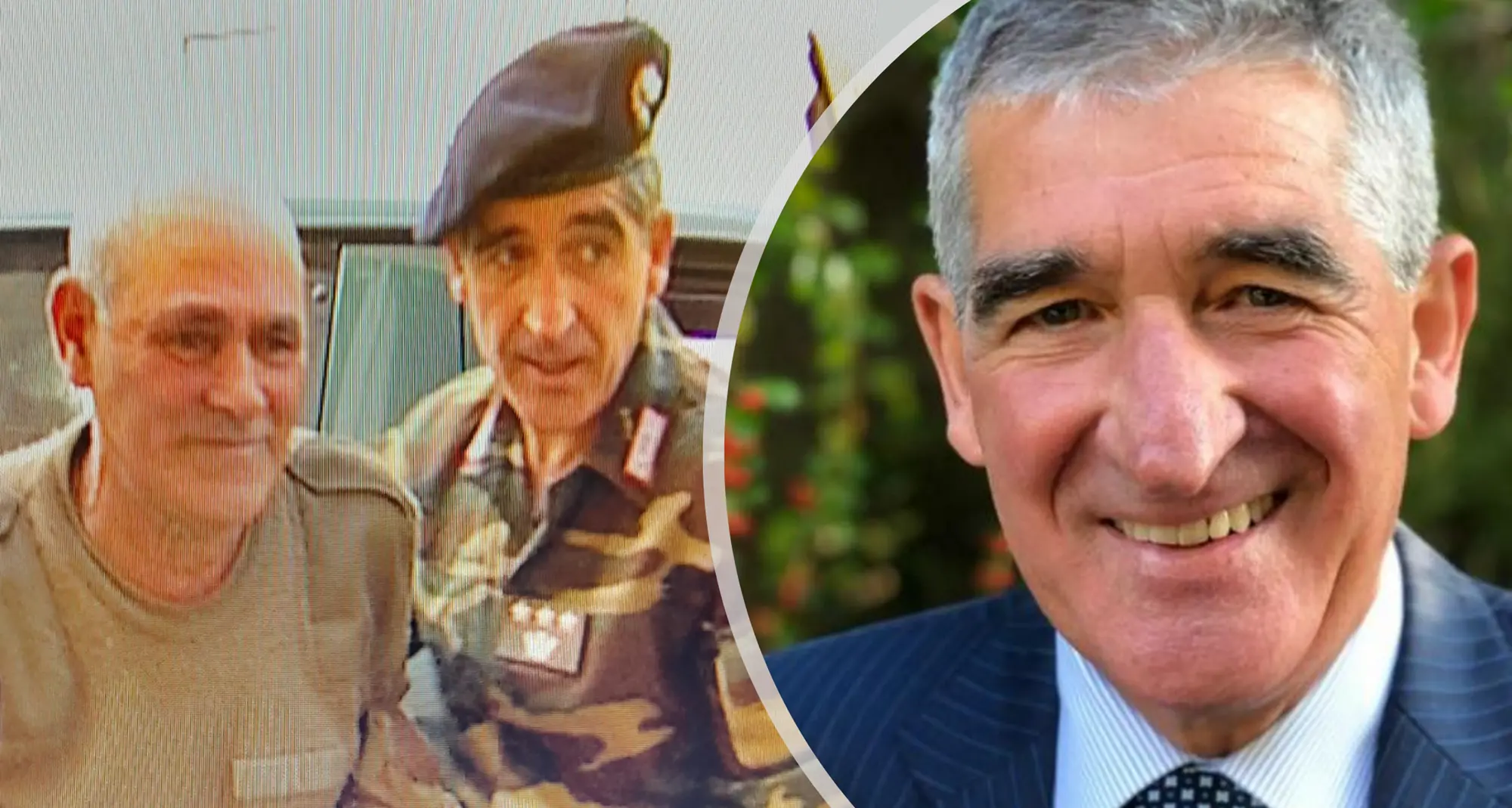PHOTO
Quella del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale è una figura istituita dal Ministero della Giustizia nel 2013. Il suo compito è tutelare i diritti fondamentali delle persone che, per diverse ragioni, si trovano in una condizione di privazione o limitazione della libertà personale. Non solo detenuti ordinari, ma anche persone internate nelle Rems o soggetti trattenuti nelle strutture di accoglienza per l’espulsione e il rimpatrio. Un compito arduo, volto alla difficile ricerca di una sintesi fra la difesa della giustizia e la garanzia delle prerogative di chi vive la disperazione della reclusione. Un impegno di civiltà, che spalanca per chi lo interpreta una finestra sugli abissi del mondo invisibile di chi soffre la pena della condanna e un’interpretazione spesso distorta del concetto stesso di detenzione.
Irene Testa è testimone preziosa di una dimensione che ha abbracciato come missione civile. Tesoriera nazionale del Partito Radicale, di cui è storica esponente, è giornalista, saggista e conduttrice radiofonica. Garante dei detenuti in Sardegna dal 2023, è attenta da oltre un ventennio alla tematica carceraria.
È stata animatrice di importanti iniziative legate alla realtà e alle politiche del sistema penitenziario italiano, degli ospedali psichiatrici giudiziari, delle case famiglie per minori e delle detenute madri. Ideatrice e conduttrice della rubrica Lo stato del Diritto, su Radio Radicale, è autrice, fra gli altri, del libro Il Fatto non sussiste, storie di orrori giudiziari, con la prefazione di Gaia Tortora.
Nel corso della sua attività come consulente parlamentare, ha elaborato disegni di legge in tema di giustizia, carceri e amministrazione penale, tra cui l’introduzione del reato di tortura nell'ordinamento italiano. Ha fatto parte di numerose delegazioni parlamentari con le quali ha visitato oltre 100 istituti di pena.
La abbiamo intervistata.
Quali sono le maggiori criticità dell’ambito carcerario in Sardegna?
«Il sistema vive una crisi profonda, principalmente a causa del sovraffollamento. Abbiamo strutture che ormai sono dei paesi per il numero di popolazione contenuta. Uta ha superato le 760 presenze, Bancali si avvia verso le 600, dal mese di agosto a oggi registriamo addirittura 100 presenze in più. Altre emergenze sono la carenza di personale, l'alto numero di persone malate e con disagi psichiatrici, tanti tossicodipendenti e tanti stranieri. Più di 1.000 persone non sarde scontano la pena nell’Isola, contribuendo all’aumento della popolazione carceraria. Il personale è poco e allo stremo delle forze. Abbiamo agenti che da soli gestiscono sezioni da 150-200 persone».
Cosa manca dal punto di vista materiale?
«Mi sono confrontata con situazioni in cui mancavano persino i materassi, le coperte, i detenuti pativano il freddo. Le istituzioni sono incapaci di far fronte alle esigenze e costringono le direzioni degli istituti ad arrangiarsi. In molte strutture non funzionano i telefoni ed è impossibile programmare regolarmente i colloqui coi parenti, che sono di vitale importanza per i reclusi».
Nel 2024 si sono registrati 86 suicidi nelle carceri italiane.
«I tantissimi tentativi di suicidio, nella maggior parte dei casi, vengono sventati dalla Polizia penitenziaria o dagli stessi compagni di cella, ma non si può pretendere che questi facciano i piantoni per prevenire le tragedie. Esistono protocolli che dovrebbero garantire una visita sanitaria all'ingresso della struttura, un supporto psicologico durante la detenzione. Tutto questo non c'è: a Uta, su oltre 760 detenuti, c'è un solo psichiatra più un'altra figura di supporto. Quest’anno abbiamo raggiunto il massimo di suicidi nella storia della Repubblica e il governo e le istituzioni danno segnali di abbandono e indifferenza».
L’emergenza sanitaria che riguarda la Sardegna si riflette nelle carceri.
«Servirebbero più psicologi, psichiatri e infermieri. Al detenuto viene data la terapia, ma nessuno controlla come viene assunta, se viene buttata, regalata o venduta ad altri detenuti. Disagi psichiatrici e fasi depressive importanti non possono essere affrontate dentro una cella. Mi capita di trovare sempre più spesso ragazzi dai 18 ai 30 anni con una doppia diagnosi. Significa che l’assunzione di stupefacenti ha slatentizzato e determinato lo sviluppo di disturbi psicopatologici. A Uta si sono dimessi tutti i medici, non è più in funzione il servizio 118. È drammatico perché in carcere ci sono eventi critici ogni ora, persone che tentano di impiccarsi, che si tagliano in continuazione. Ma non funziona nulla. Ci sono persone che entrano nelle strutture sulle proprie gambe ed escono in sedia a rotelle, perché aspettano per anni una visita specialistica che non arriva, complice la loro situazione di indigenza».
Spesso, dietro i detenuti, c’è il dramma delle famiglie incapaci di affrontare queste situazioni.
«Le alterazioni sfociano in famiglia con maltrattamenti, comportamenti ingestibili. Così i parenti, disperati, chiedono aiuto ai servizi territoriali che nella gran parte dei casi non riescono ad aiutarli all'esterno. Spesso sono proprio le agenzie sul territorio che consigliano ai genitori di denunciare i figli per attivare i percorsi che portano i ragazzi in comunità. Ma questi percorsi in realtà aprono spesso le porte del carcere. Ricevo chiamate di decine di mamme che speravano di portare i figli nei centri di recupero, invece se li ritrovano in carcere in piena psicosi maniacale».
A quel punto diventa sempre più difficile accedere alle comunità?
«Quando si entra in questo circolo vizioso, il carcere non è in grado di gestirli e curarli. Le comunità, poi, sono poche, spesso non hanno i finanziamenti adeguati o semplicemente non ci sono posti. È veramente un girone infernale e nessuno sa più come gestirlo».
Come può un Paese che vuole dirsi civile assistere inerme a questo imbarbarimento? E quali sono gli interventi urgenti auspicabili?
«Si tende a nascondere dentro un contenitore tanti problemi che non si riesce a risolvere fuori. Servono interventi normativi volti ad alleggerire in primis il peso umano delle carceri. Per riabilitare realmente il detenuto servono percorsi personalizzati di lavoro, cura, coinvolgimento, ma anche di affettività perché molti detenuti, soprattutto tossicodipendenti, sono talmente fragili che hanno bisogno semplicemente di affetto. Basta una piccola delusione, un colloquio andato male per farlo crollare. Poi occorrono strutture nuove».
L’esperimento delle colonie penali in Sardegna come lo vede?
«Sono il fiore all'occhiello per la Sardegna, il luogo dove si effettua la vera detenzione, così come ci indica la Costituzione. Ma sono semivuote e semiabbandonate. Quando i dirigenti di certe amministrazioni vengono in Sardegna a visitarle le lodano, ne assaggiano i prodotti. Però non si fa niente per rendere queste colonie agricole realmente efficienti e produttive. È un peccato perché credo siano una realtà unica non solo nel panorama italiano, ma addirittura europeo ed extraeuropeo. Un modello che, se ben applicato, potrebbe essere esportato ovunque».
Per quanto riguarda i detenuti con disagi psicologici, dopo la dismissione degli Opg sono state istituite le Rems, ma anche questa soluzione è oggi messa in discussione.
«Dopo la chiusura degli Opg è stato fatto il grande errore di non creare le strutture territoriali in grado di accogliere chi usciva da questi luoghi. In Sardegna abbiamo una Rems di 16 posti a Capoterra che lavora benissimo. Ho visto persone completamente perse in carcere, curate nelle celle lisce senza materasso, lenzuola, coperte, mangiavano per terra con i piatti di plastica perché dentro queste celle, visto l’alto rischio suicidario, non ci sono nemmeno arredi. Là dentro diventano persone senza più dignità e umanità. Bene, trasferite nella Rems, sono oggi irriconoscibili: stanno meglio, hanno fatto un percorso personalizzato, sono state curate. Purtroppo, sono pochi i recuperi di questo tipo perché c'è tanta gente in lista d'attesa, anche in questo caso bisognerebbe investire sulle strutture».
Cosa pensa della proposta di depenalizzare alcuni reati per smaltire il sovraffollamento?
«Totalmente d'accordo. Se ci fossero state politiche di legalizzazione, non ci ritroveremmo con un numero così elevato di ragazzi in doppia diagnosi e disagi dovuti all’assunzione di droghe. Oggi le sostanze sono molto diverse dal passato. Mentre un tempo esistevano addirittura i farmaci corrispondenti alle droghe classiche, per le nuove sostanze non esistono. Significa che se il ragazzo slatentizza un problema psichiatrico, difficilmente si riesce a trovare il farmaco corrispondente. Quindi è condannato a un disagio permanente. Questo è frutto del mercato illegale».
Ci spiega meglio?
«Le sostanze che circolano in un mercato clandestino, chiaramente, hanno effetti molto più nocivi di quelli che avrebbero se il mercato fosse controllato. Se le sostanze non fossero così aggressive, sarebbe più facile curare la dipendenza con antipsicotici e farmaci che consentirebbero ai tossicodipendenti di ritornare a una qualche normalità. La politica, priva di coraggio, preferisce invece un mercato clandestino con tutte le conseguenze che conosciamo anche dal punto di vista economico».
In questi giorni si è tornati a parlare della vicenda del boss Raduano, evaso nel 2023 da Badu ‘e Carros. Nelle carceri sarde c'è anche un problema di sicurezza?
«Gli agenti sono pochi e non supportati. Sono immersi in questa sofferenza con cui hanno a che fare, spesso costretti a occuparsi di cose che non gli competono, vista la mancanza di figure professionali adeguate: consolare i detenuti durante una crisi, intervenire quando non hanno nemmeno i vestiti. È chiaro che in una situazione del genere, anche dal punto di vista della sicurezza ci saranno dei problemi».
Qual è la fotografia della carcerazione minorile nell’Isola?
«A Quartucciu abbiamo meno di dieci ragazzi custoditi all'interno di un istituto nato come carcere di massima sicurezza per terroristi. Una situazione assurda e paradossale, un’enorme struttura con le mura altissime abbandonata, sezioni a rischio crollo, sprechi e costi enormi, perdite d'acqua e infiltrazioni, dispersioni di corrente. Durante la mia ultima visita ho trovato i secchi nelle stanze degli agenti perché ci piove dentro. Non sono rispettati i minimi standard di agibilità e vivibilità. Si è finanziata una ristrutturazione da 3,5 milioni di euro che ha riguardato solo una piccola palazzina con 7-8 camere, ma l'attività di chi lavora e dei ragazzi si svolgerà nell'ala compromessa e non cambierà quasi nulla».
Di recente si è parlato dell'abolizione delle carceri minorili, come la vede?
«Sono del parere che gli istituti minorili possano e debbano essere superati. Il fatto che lo Stato non riesca a puntare sui ragazzi per riabilitarli è un fallimento. Hanno sbagliato, ma sono giovanissimi, non è chiudendoli dietro le sbarre che li recupereremo. Facciamoli studiare e lavorare, diamogli la possibilità di vivere in un contesto propositivo. Il carcere deve essere l'extrema ratio perché abbruttisce, ti fa sentire un delinquente. Ma negli ultimi anni assistiamo a una politica sempre più improntata alla sicurezza, alla punizione, al castigo. Serve un cambiamento culturale».
Come si può educare la società a considerare i detenuti come persone con diritti piuttosto che individui da emarginare?
«È molto difficile, capisco l'emotività dell’opinione pubblica, soprattutto di fronte a fatti particolarmente efferati. Ma i detenuti sono persone e bisogna lavorare per prepararli al giorno in cui torneranno nella società. Prima o poi, la maggior parte di questi individui lascia il carcere. È un'illusione pensare che li mettiamo dentro e siamo tranquilli, se non faranno dei percorsi che li aiutino a comprendere gli errori, usciranno sicuramente più incattiviti di come sono entrati».
Lei si è occupata in prima persona delle criticità del Cpr di Macomer, qual è la situazione oggi?
«I migranti che vi sono ospitati sono praticamente chiusi dentro le celle di una struttura che è un vecchio carcere di massima sicurezza. Non fanno niente tutto il giorno, stanno in terra perché non hanno neanche le sedie nei corridoi e, anche lì, spesso pensano a come togliersi la vita. D’inverno vivono al gelo, d’estate con temperature di 40°C, costretti a mettere le coperte nelle finestre per ripararsi dal sole. Le lenzuola sono realizzate in una sorta di plastica che dà irritazione alla pelle. Non possono contattare i parenti telefonicamente. Rimangono nel Cpr per 18 mesi e dopo, quando non riusciamo a rimpatriarli, li rimettiamo in strada senza nemmeno vestiti. È un sistema folle».
C’è un argomento che continua a essere un tabù quando si parla di carceri: il sesso. Oggi si parla di camere dell’amore nelle quali i detenuti potrebbero incontrare le proprie mogli o fidanzate. Qual è il suo parere a riguardo?
«La penso esattamente come la Corte Costituzionale ha sancito recentemente con una sentenza, cioè che il carcere debba garantire l'affettività ai detenuti. A questo proposito ho scritto a tutti gli istituti della Sardegna per capire se fosse stata recepita la disposizione della sentenza. Purtroppo, ancora, non è stata messa in atto in nessuna delle strutture isolane, che però dovranno necessariamente adeguarsi. Anche chi sbaglia ha diritto a poter abbracciare la moglie, a trascorrerci del tempo, così come a trascorrerlo con i figli. Che male c’è nel concedere una giornata piuttosto che 40 minuti di colloquio? Non ha senso accanirsi privando i detenuti di tutto. Sottrarre gli affetti familiari non è contribuire alla rieducazione, serve a inasprire gli animi di queste persone».
Qual è la storia che l’ha affranta di più e quella che l'ha sorpresa di più in positivo?
«Penso alla storia di una persona inferma di mente che ha compiuto un reato molto grave, di quelli per cui l'opinione pubblica chiede di buttare la chiave e basta. Ho avuto modo di fare dei colloqui con lei poco dopo, era incapace di intendere e volere. A distanza di mesi l'ho rincontrata trovandola completamente investita dal dolore che col tempo ha provato nel ricordare il gesto che aveva commesso. Una sofferenza enorme che mi ha trasferito totalmente. Una volta rientrata a casa, sono stata male come mai prima di allora. Ricordo, invece, di un ragazzo molto giovane che vedevo all'interno del carcere completamente disperato e dissociato, con sdoppiamenti di personalità. Dopo un anno, si è riusciti a farlo accedere alla Rems e oggi lo sento spesso, sono andata a trovarlo e ho trovato una persona rinata. Hanno fatto su di lui un lavoro bellissimo che spero possa proseguire. Mi fa un enorme piacere, poi, rimanere in contatto con le mamme di questi giovani che mi aggiornano sulla situazione dei loro figli quando finalmente riescono a intraprendere una buona strada di recupero».
Come fa a tornare a casa e riprendere la vita di tutti i giorni dopo essere stata a contatto con storie così drammatiche?
«Ci sono giorni in cui ho proprio bisogno di staccare, tante sono le richieste di aiuto che mi arrivano e le testimonianze di disgrazie e disperazione che raccolgo come garante. Ci sono momenti in cui ti senti impotente. Il diritto è il faro che guida il mio lavoro, ma sebbene il garante abbia un potere di controllo e interlocuzione, non può risolvere tutto. A volte, a fine giornata, capita che l’emozione prenda il sopravvento e mi travolga».